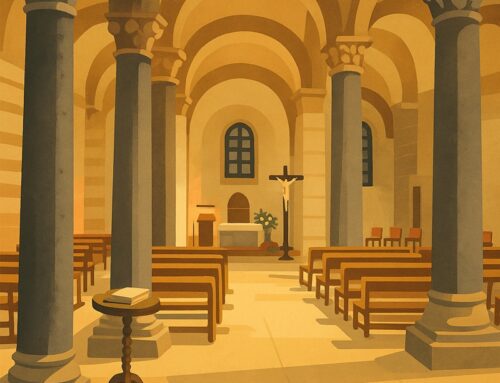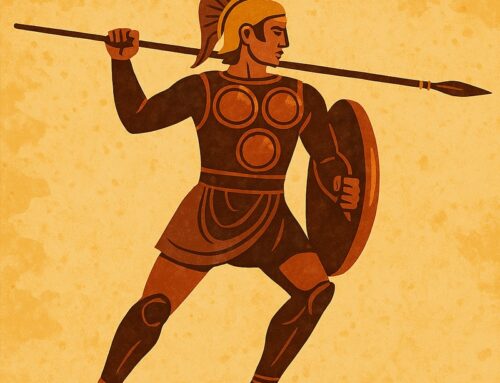Streghe, Janare ed Incantesimi
Il Sannio, incastonato nel cuore della Campania e proteso tra Molise e Abruzzo, è una terra da sempre celebrata per la sua ricca tradizione vinicola e la sua storia millenaria.
Tuttavia, al di là dei paesaggi pittoreschi e dei rinomati vini Falanghina e Aglianico, questa regione custodisce un’anima più profonda e misteriosa, un lato esoterico che affonda le radici in credenze antiche e pratiche popolari.
Il Sannio si rivela come una gemma nascosta non solo per gli amanti del vino e della storia, ma anche per coloro che desiderano esplorare un patrimonio magico vibrante e, a tratti, inquietante.
Questo territorio è un vero e proprio scrigno di leggende, dove la figura della “strega”, in particolare l’infame “Janara”, e quella delle “inciarmatrici” (guaritrici popolari) si intrecciano in un dualismo affascinante, tra timore e potere curativo.
Il presente articolo si propone di esplorare le radici storiche, le pratiche e l’eredità duratura di queste figure mistiche, invitando il lettore a un viaggio attraverso i sentieri nascosti del folklore sannita.
Terra di Storia, Miti e Vini Antichi
Il Sannio, l’antica Samnium, fu abitato dai Sanniti, un popolo italico di stirpe osca, la cui presenza è documentata tra il VII-VI secolo a.C. e il I secolo d.C.. La regione è prevalentemente montuosa, sviluppandosi intorno al massiccio del Matese, e vanta una geografia unica con terreni argillosi, calcarei e vulcanici, ideali per la coltivazione di vitigni autoctoni.
La storia del Sannio è segnata da importanti transizioni culturali. Dopo la vittoria romana su Pirro nel 275 a.C., l’antica Maleventum, il cui nome evocava un “cattivo presagio”, fu ribattezzata Beneventum, a significare un “buon auspicio”. Questo cambiamento nominale, da un’accezione negativa a una positiva, suggerisce una connessione intrinseca della regione con il destino e le credenze. Un periodo cruciale per la genesi delle leggende stregonesche fu l’era longobarda, a partire dal VI secolo, quando Benevento divenne la capitale di un potente ducato. I rituali pagani dei Longobardi si scontrarono con le credenze cristiane della popolazione locale, creando un terreno fertile per interpretazioni mistiche e demonizzazioni. Questa successione di dominazioni e l’incontro di diverse culture hanno dato vita a un complesso intreccio di tradizioni, dove il sincretismo ha agito come una forza plasmatrice. Le figure esoteriche del Sannio non sono il frutto di una singola tradizione, ma piuttosto un ricco mosaico intessuto da secoli di scambi culturali e conflitti, conferendo al folklore una notevole profondità e resilienza.
Benevento, in particolare, ha guadagnato il soprannome di “città delle streghe”. Questa reputazione è profondamente radicata nell’identità cittadina, trasformandola in un vero e proprio “museo a cielo aperto” di storia e mito. La profonda connessione delle leggende con l’ambiente fisico del Sannio è evidente: il fiume Sabato, le sue gole come lo “Stretto di Barba”, e il leggendario Noce di Benevento sono luoghi specifici e tangibili che fungono da palcoscenico per eventi soprannaturali. Questo legame intrinseco tra il paesaggio e le narrazioni mistiche conferisce alle storie una maggiore autenticità e potenza per gli abitanti, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di percepire la storia e il mistero del luogo.
Le Streghe ed il Noce Misterioso
Le Janare, figure centrali del folklore sannita, hanno origini che si perdono nei culti pagani di divinità femminili potenti come Diana, Iside ed Ecate, associate alla magia, alla luna e all’oltretomba. Una teoria diffusa lega la loro nascita ai Longobardi che, pur convertendosi al Cristianesimo, mantennero vive le loro usanze ancestrali. Questi riti pagani, come le cerimonie in onore di Wotan (Odino) sulle rive del fiume Sabato, che prevedevano persino il ferimento di un cavallo e il consumo della sua carne cruda, furono percepiti dalla popolazione cristiana come “orgie infernali” e contribuirono alla nascita delle prime narrazioni sulle streghe. Il nome stesso “Janara” si ritiene derivi da “Dianara”, sacerdotessa di Diana, o da “ianua” (porta), alludendo alla loro capacità di insinuarsi sotto le soglie. Già nel 1639, l’opera di Pietro Piperno, “Della superstitiosa noce di Benevento”, testimoniava l’esistenza di queste credenze nel VII secolo.
Le Janare erano comunemente descritte come figure solitarie, scortesi e aggressive. Di giorno assumevano l’aspetto di donne comuni, ma di notte si trasformavano in esseri terrificanti con capelli sporchi, occhi spiritati e unghie lunghissime. Si credeva che volassero ai loro sabba dopo essersi unte il corpo nudo con un unguento magico, che le rendeva anche invisibili e permetteva loro di passare sotto le porte.
Le loro azioni malefiche erano numerose e temute. Si intrufolavano nelle stalle per rapire le giumente e cavalcarle fino all’alba, lasciando le criniere annodate in treccine, e si pensava che scioglierle avrebbe causato la morte dell’animale. Spesso, le Janare erano accusate di provocare una sensazione di soffocamento notturno, oggi spiegata scientificamente come paralisi del sonno, ma che nel folklore trovava una spiegazione soprannaturale. Erano considerate particolarmente crudeli con i bambini, causando loro soffocamento, tormento, aborti, infertilità e morti in culla. Altri malefici includevano lo scatenamento di tempeste, la distruzione dei raccolti, forti emicranie e paralisi. Per difendersi dalle Janare, la tradizione popolare suggeriva di posizionare una scopa o un sacchetto di sale davanti alla porta, costringendole a contare i fili o i grani fino all’alba, momento in cui perdevano il loro potere. Altri rimedi includevano appendere piccole forbici aperte o un occhio di lupo al collo dei bambini, o posizionare un libro religioso sotto il materasso. Si credeva che afferrare una Janara per i capelli potesse garantire protezione per sette generazioni.
Il fulcro indiscusso delle leggende stregonesche è il mitico Noce di Benevento. Questo albero leggendario era il luogo di ritrovo per i “Sabba”, dove streghe da ogni dove si riunivano per riti, danze e celebrazioni orgiastiche. Sebbene la sua ubicazione fisica sia oggi incerta, la tradizione orale lo colloca in diversi punti, inclusi i terreni del nobile Francesco di Gennaro o la gola dello “Stretto di Barba”. I sabba erano descritti come eventi che potevano includere violenza iconoclasta e persino atti di cannibalismo, richiamando i tiasi dionisiaci. Anche la notte di San Silvestro era un momento significativo per i loro rituali, con l’intento di influenzare il destino dell’anno a venire. La celebre formula “Unguento unguento / Portami al noce di Benevento / Supra acqua et supra vento et supra ad omne malo tempo” era recitata dalle streghe per volare verso il Noce. Il Noce, in questo contesto, assume la funzione di uno spazio liminale, una soglia tra l’ordinario e lo straordinario, il mondo umano e quello soprannaturale, il cristiano e il pagano. La sua persistenza nel folklore, nonostante i tentativi di soppressione, sottolinea il potere duraturo di un luogo dove i confini si dissolvono, permettendo azioni sia terrificanti che, in un certo senso, liberatorie.
Oltre alle Janare, il folklore sannita annovera altre figure stregonesche. La Zucculara, una strega zoppa che infestava l’area del Triggio (vicino al Teatro Romano), prendeva il nome dai suoi zoccoli rumorosi. La sua figura è associata alla dea greca Ecate, venerata ai trivi (incroci) e raffigurata con un solo sandalo. La Manalonga, invece, era una strega con un braccio lungo che abitava nei pozzi e attirava i passanti nelle profondità, riflettendo la paura ancestrale delle fosse e delle buche come possibili varchi per l’oltretomba. Figure simili si ritrovano in altre regioni del Sud Italia, come le Maciare in Irpinia, le Stiare in Puglia e le Cogas o Bruxas in Sardegna, evidenziando un substrato culturale condiviso. Questa demonizzazione delle figure femminili con conoscenze alternative, come le erbaie o le levatrici, e la loro associazione con il male, riflette un processo storico di controllo sociale e di soppressione delle forme di autonomia femminile nelle comunità rurali.
Figure Esoteriche del Sannio
| Nome Figura | Caratteristiche Distintive | Leggende/Poteri Associati |
|---|---|---|
| Janara | Solitaria, scortese, aggressiva; appare come donna comune di giorno, spaventosa di notte; vola con unguento, si infila sotto le porte. | Rapisce giumente e ne intreccia le criniere; provoca soffocamento notturno (paralisi del sonno); causa aborti, infertilità, morti in culla. |
| Zucculara | Zoppa; indossa zoccoli rumorosi; infesta il Triggio (Teatro Romano). | La sua figura si ispira alla dea Ecate, venerata ai trivi, che portava un solo sandalo. |
| Manalonga | Possiede un braccio lungo; abita nei pozzi. | Tira giù chiunque passi nelle vicinanze; i pozzi sono visti come varchi per l’inferno. |
Le Inciarmatrici
A differenza delle Janare, le “inciarmatrici” (o curatrici, erbaie) rappresentavano figure di guarigione e protezione nel Sannio. Erano donne che assistevano le famiglie con la medicina popolare e proteggevano dal “malocchio”. Possedevano una profonda conoscenza delle erbe officinali e alimurgiche, utilizzate per preparare pozioni, filtri e unguenti. Alcune fonti suggeriscono che fossero spesso donne vedove o single che distillavano erbe, e i risultati, talvolta letali, potevano portare alla loro demonizzazione.
Le loro pratiche di guarigione si basavano su un’operatività “magico-rituale” che combinava magia, divinazione e azioni terapeutiche. Un esempio è l’atto di “inciarmare” i vermi, un rituale preliminare per immobilizzarli e renderli inoffensivi, spesso riferito a crisi convulsive nei bambini attribuite ai vermi ma in realtà legate all’innalzamento della temperatura corporea. Questa medicina tradizionale era personalistica, e i praticanti, spesso paragonati a “maghi o stregoni”, operavano al di fuori dei circuiti medici formali. La capacità di guarire veniva spesso trasmessa oralmente, in particolare la notte di Natale, attraverso la condivisione di segni e parole. I veri guaritori, si diceva, dovevano essere generosi, mantenere il segreto sui riti e accettare solo doni spontanei, non denaro.
La medicina popolare del Sannio è ricca di conoscenze erboristiche. Le “erbe di San Giovanni”, raccolte nella notte del solstizio d’estate (23-24 giugno), erano considerate particolarmente potenti grazie alla “rugiada magica”. Queste erbe venivano spesso legate in mazzetti con sette nodi e poste all’ingresso delle abitazioni per proteggere dal malocchio e dagli incantesimi.
L’uso dei nodi era un’altra pratica comune tra streghe e Janare. Il nodo simboleggiava la concentrazione di forze, utilizzato per incantesimi d’amore (legando simbolicamente una coppia) o per rendere gli uomini impotenti. Il “nodo di Iside” nell’antico Egitto simboleggiava l’eternità. Il canto rituale era essenziale per infondere energia nell’azione e nel materiale.
Il confine tra guaritrice rispettata e strega temuta era spesso labile, specialmente durante i periodi di persecuzione religiosa. Figure come Bernardino da Siena predicavano contro le donne che praticavano la medicina popolare, contribuendo alla loro demonizzazione. Se i rimedi fallivano o avevano effetti avversi, queste donne potevano essere facilmente accusate di stregoneria, evidenziando la precarietà della loro posizione sociale. Le tradizioni esoteriche del Sannio rivelano come le società interpretassero e rispondessero a fenomeni inspiegabili, siano essi naturali o fisiologici, attraverso una combinazione di credenze magiche, osservazioni pratiche e meccanismi di controllo sociale. La medicina popolare, sebbene pre-scientifica, rappresentava un sistema funzionale di assistenza sanitaria che offriva conforto e cura in un ambiente difficile, e la sua demonizzazione comportò la perdita di preziose risorse comunitarie.
La Caccia alle Streghe
La persecuzione delle streghe in Europa si intensificò a partire dal XV secolo, alimentata da testi come il Malleus Maleficarum (1486), che forniva linee guida per l’identificazione e la tortura delle presunte streghe. Si stima che oltre 50.000 persone furono condannate a morte in Europa nell’arco di tre secoli. Anche nell’Italia meridionale, sebbene inizialmente le pene fossero rare, le accuse e i processi per stregoneria si moltiplicarono. Le vittime erano spesso individui umili e poco istruiti, facilmente manipolabili dagli inquisitori.
A Benevento, le prime tracce storiche legate alle streghe sono connesse a Bernardino da Siena, che predicava contro le donne che praticavano la medicina popolare, contribuendo alla loro demonizzazione. Il caso più celebre è quello di Matteuccia di Francesco, detta Matteuccia da Todi, processata nel 1428. Questo fu il primo processo in cui fu esplicitamente usata la parola “strega”. Accusata di essere “incantatrice, fattucchiera, maliarda e strega”, Matteuccia contava tra la sua clientela non solo contadini ma anche personaggi di alto rango. Sotto tortura, confessò di aver volato al Noce di Benevento sotto forma di gatta a cavallo di un demone caprone. Fu anche accusata di aver ucciso cinque bambini e di aver consumato sangue di neonato, accuse che i giudici non misero mai in dubbio. Matteuccia fu bruciata sul rogo il 20 marzo 1428. Nelle carte processuali è riportata la famosa formula che Matteuccia recitava: “Unguento unguento / Portami al noce di Benevento / Supra acqua et supra vento et supra ad omne malo tempo”. Questa frase fu ripetuta anche da Mariana di San Sisto, condannata al rogo nel 1456, con riferimenti al Noce e al Sabba. Altri processi del XVI secolo menzionano Benevento e il Noce, come quelli di Bellezza Orsini, esperta di erbe medicinali, e Faustina Orsi, arsa viva a 80 anni.
Tragicamente, gran parte delle testimonianze storiche sui processi di stregoneria a Benevento sono andate perdute. Oltre 200 verbali dell’archivio vescovile furono distrutti nel 1860 per evitare sentimenti anticlericali, e un’ulteriore parte scomparve a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante questa perdita, le leggende delle streghe di Benevento, in particolare delle Janare e del Noce, sono sopravvissute e si sono persino rafforzate, dimostrando la notevole resilienza della tradizione orale e della memoria culturale. La caccia alle streghe, influenzata da figure come Bernardino da Siena, rappresentò uno strumento di controllo sociale e religioso, mirando a sopprimere le forme alternative di conoscenza e influenza, specialmente tra le donne emarginate delle comunità rurali. La persistenza di queste narrazioni, anche in assenza di documenti completi, sottolinea il potere duraturo del racconto e la sua capacità di diventare parte integrante dell’identità di una regione.
Eredità Esoterica
Le Janare continuano a essere una fonte di timore e fascino nel Sannio, e le loro storie sono ancora narrate in molti villaggi, spesso con varianti locali. Sebbene la scienza moderna possa spiegare fenomeni come la paralisi del sonno (il “soffocamento” attribuito alle Janare) , le leggende persistono, consentendo una rispettosa distinzione tra mito e realtà scientifica, pur preservandone il fascino culturale. Questa persistenza del mistero, nonostante le spiegazioni razionali, evidenzia un bisogno umano intrinseco di narrazione e connessione con un passato più profondo e magico.
Benevento abbraccia con orgoglio il suo soprannome di “città delle streghe”, rendendo questo patrimonio esoterico un elemento centrale della sua identità. Le leggende, un tempo fonte di paura e persecuzione, sono state trasformate in un significativo asset culturale ed economico. Un esempio lampante è il famoso Liquore Strega, prodotto a Benevento e direttamente ispirato alle leggende delle streghe, rappresentando una materializzazione commerciale di successo del folklore. Il balletto “Noce di Benevento” di Franz Xaver Süssmayr (1802) ha ulteriormente consolidato la leggenda nella cultura più ampia.
Oggi, il Sannio offre esperienze turistiche dedicate al suo lato misterioso. Tour specifici, come la “Janare Experience” di Sannio Experience, invitano i visitatori a esplorare i vicoli di Benevento ascoltando racconti di streghe e riti antichi, guidati da esperti. Questi percorsi sono presentati come un’opportunità per “varcare una soglia temporale” e scoprire una Benevento che è “molto più di quello che appare”. La regione vanta anche altri luoghi “segreti” ed esoterici, come l’Obelisco Egizio (testimonianza dell’antico misticismo di Benevento), il Museo Strega, le misteriose Piramidi del Sannio (vicino a Sant’Agata dei Goti) e il “Giardino del Mago”. Anche le feste e le tradizioni locali, come il Carnevale di Sant’Agata dei Goti con i suoi dodici attori che rappresentano i mesi e un tredicesimo per il Capodanno, richiamano antichi cicli agricoli e periodi di transizione, riecheggiando l’attività delle Janare in tali momenti. La ricca gastronomia sannita, con piatti tipici come le “cinque C” della cucina beneventana e il croccantino, si intreccia con questa identità culturale, offrendo ai visitatori un’esperienza completa.
La trasformazione delle leggende da fonte di terrore a risorsa culturale ed economica dimostra la capacità di una comunità di riappropriarsi e reinterpretare il proprio passato. Il Sannio, in questo senso, è un esempio di come un folklore profondamente radicato, anche se legato a eventi storici oscuri, possa diventare una fonte di orgoglio, identità e turismo sostenibile, forgiando un marchio regionale unico.